Le tensioni tra la leadership politica e spirituale nel periodo dei Saggi, e tra entrambe e il potere di Roma in Terra d’Israele, sono al centro di un nuovo libro che intreccia artisticamente diverse fonti e crea un quadro storico per il mondo dei saggi del Talmud gerosolimitano
Chaim Shapira – Makor Rishon – 31 Ottobre 2025
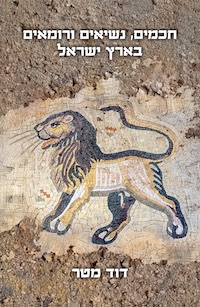
L’affascinante libro di David Matar cerca di presentare la storia politica del periodo del Talmud gerosolimitano. Al centro del libro ci sono le relazioni, generalmente tese, tra i Maestri e i Principi (Nesi’im) – i leader politici del popolo ebraico in questo periodo. L’origine della dinastia dei Principi è radicata proprio nel mondo dei Maestri. Rabbi Yehuda HaNasi, redattore della Mishnà, è probabilmente il primo ad aver portato questo titolo, e per questo l’autore lo considera il primo dei Principi. “Rabbi”, come è comunemente chiamato, fu sostenuto dal potere romano dal punto di vista economico e politico, e questo consolidò la sua posizione come capo dei Maestri e come leader nazionale. Fu giustamente descritto come colui che ottenne “Torà e grandezza nello stesso luogo“. Suo figlio Rabban Gamliel (il Terzo) e suo nipote Rabbi Yehuda Nesi’ah facevano ancora parte del mondo dei Maestri, ma con il passare del tempo i suoi discendenti si allontanarono dal mondo dei Maestri e si stabilirono nel loro ruolo pubblico e politico.
Nella seconda metà del III secolo l’influenza dei Principi si espanse e ottennero prestigio anche tra gli ebrei della diaspora. Inviavano emissari che riscuotevano per loro tasse dalle comunità ebraiche in tutta l’Impero, e talvolta intervenivano anche nella vita delle comunità. Gli interessi dei Principi erano quindi diversi da quelli dei Maestri. Il loro impegno sociale non era rivolto (solo) ai Saggi ma a gruppi come l’aristocrazia degli ebrei della Galilea e figure di rilievo delle comunità ebraiche nella diaspora. Queste differenze portarono a tensioni e persino a scontri tra i Maestri e i Principi.
Le relazioni tra il Principe e i Maestri si svolgevano sotto gli occhi vigili delle autorità romane, che avevano i propri interessi. Prima di tutto si preoccupavano della legge e dell’ordine, e inoltre si occupavano anche del finanziamento delle loro operazioni, cioè della riscossione di vari tipi di tasse per le casse romane. Questi interessi portarono il potere romano a sostenere i Principi per la maggior parte del periodo, fino a un certo punto all’inizio del V secolo quando giunsero alla conclusione di non aver più bisogno dell’istituzione del Principato e la abolirono. In totale, dai giorni di Rabbi fino alla sua abolizione, il Principato durò più di duecento anni e per tutto il periodo fu controllato da un’unica dinastia, la dinastia di Rabbi Yehuda HaNasi.
Nel suo libro Matar descrive il sistema di relazioni tra i Maestri e il Principe dai giorni di Rabbi in poi, generazione dopo generazione, per cinque generazioni di Amoraim (Maestri del Talmud) della Terra d’Israele e al tempo di dieci Principi che l’autore riesce a identificare in questo arco di tempo (i loro nomi appaiono in una tabella all’inizio del libro). Inoltre, l’autore esamina anche le relazioni tra i Saggi stessi nelle case di studio di Tiberiade e Sepphoris, Cesarea e Lod, influenzate dalle relazioni con il Principe.
Una descrizione continua di questo tipo crea una sfida complessa, poiché le fonti talmudiche non forniscono i dati necessari. Le fonti non forniscono una cronologia di base del periodo, come quando fu nominato ogni Principe e quando morì o lasciò il suo seggio; non menzionano i nomi di tutti i Principi che servirono in questo periodo, e quelli che operarono nel IV secolo sono quasi completamente assenti. Anche gli anni di attività dei Maestri dobbiamo completarli da altre fonti, come la Lettera di Rav Sherira Gaon scritta nel X secolo. Poiché lo scopo delle fonti talmudiche non è scrivere storia, esse non forniscono descrizioni complete degli eventi sociali e politici che si verificarono in quel tempo. In assenza di un altro storico contemporaneo che abbia fatto un tale lavoro, rimaniamo con pezzi di informazione parziali e frammentati. Per descrivere la storia politica del periodo e costruire una narrazione continua, è quindi necessario colmare molte lacune.
L’autore si è assunto questa sfida, e lo fa con grande abilità e creatività e sulla base di una conoscenza ampia e approfondita. Conosce bene le fonti talmudiche e i midrashim dell’Aggadà; conosce anche le fonti esterne, gli scritti degli autori romani e dei Padri della Chiesa rilevanti per la questione, e i ricchi reperti archeologici. Di tutte queste fonti fa un uso intelligente, avvalendosi dell’abbondante letteratura di ricerca scritta su di esse.
Il comitato per la nomina dei giudici
Per oltre quarant’anni l’autore, Dr. David Matar, ha lavorato come pediatra. Allo stesso tempo, nel corso degli anni si è molto interessato alla storia ebraica, e in particolare a quella del Secondo Tempio e del periodo della Mishnà e del Talmud. Alcuni anni fa ha iniziato a studiare e ricercare sistematicamente il Talmud gerosolimitano alla luce delle fonti esterne e della letteratura di ricerca. Di conseguenza ha intrapreso il progetto attuale, e l’impressionante risultato è ora davanti a noi.
Dal punto di vista del genere, il suo libro ricorda la serie “Chachamim” (Saggi) del rabbino Binyamin Lau. Vale a dire, non si tratta di un libro di ricerca destinato a ricercatori professionisti e intenditori soltanto, ma di un libro di saggistica accessibile a chiunque desideri conoscere. Presenta le fonti, le interpreta e le analizza e ne trae conclusioni storiche originali. Il punto di vista di Matar è realistico e lucido. Il lettore apprende che la società in cui operavano i Maestri era una società normale in cui le persone, compresi i Saggi, agiscono sulla base di interessi personali, sociali, economici e politici. I Maestri avevano ovviamente valori e posizioni di principio su varie questioni, ma non si possono comprendere le loro azioni solo da un punto di vista idealistico.
La forza particolare dell’autore è collocare una controversia halakhica o un’interpretazione aggadica in un contesto storico e sociale che la illumina sotto una nuova luce. Ecco un esempio che occupa un posto centrale nel libro. Nel Talmud gerosolimitano (Bava Batra 8, 1) si racconta di un acceso dibattito che si svolse tra Yehuda Nesi’ah e R’ Yochanan e R’ Yannai sulla questione dell’eredità della figlia. Yehuda Nesi’ah (secondo l’autore si tratta di Yehuda Nesi’ah II, bisnipote di Rabbi) entra nel Consiglio a Tiberiade e cerca di convincere R’ Yochanan, il più anziano dei Maestri, e il suo vecchio maestro R’ Yannai, che bisogna interpretare i versetti della Torà in modo che la figlia erediti in parti uguali con i figli maschi. R’ Yochanan reagisce alla sua proposta con rabbia e lascia il Consiglio insieme a R’ Yannai, concludendo: “Quest’uomo (Yehuda) non è interessato ad ascoltare parole di Torà“.
L’autore nota che si tratta di una controversia di principio ed eccezionale nella sua asprezza, e propone per essa un contesto storico e sociale. Secondo la legge romana, la figlia eredita in parti uguali con il figlio maschio. Al contrario, secondo la legge ebraica, quando c’è un figlio maschio – la figlia non eredita. L’autore ipotizza che le donne ebree appartenenti all’alta società delle città della Galilea entrarono in contatto con le loro amiche non ebree e si sentirono discriminate per il fatto di non avere diritto all’eredità. Mobilitarono i loro mariti e vennero insieme con la richiesta di equiparare le figlie ai figli maschi nel diritto successorio, e riuscirono a coinvolgere nella questione anche il Principe che si sentiva impegnato verso questo gruppo. Yehuda Nesi’ah si rivolse quindi ai Saggi nel tentativo di ottenere da loro l’approvazione per modificare la legge e equiparare figlie e figli nell’eredità, ma fu fermamente respinto.
Secondo l’autore, questo episodio fu un punto di svolta nella formazione del sistema giudiziario nel periodo del Talmud. Il fondatore della dinastia, Rabbi Yehuda HaNasi, sfruttò la sua autorità di nominare giudici per nominare Maestri a questo ruolo e garantire che i tribunali operassero secondo la Halakhà. In questo modo continuarono suo figlio Rabban Gamliel e suo nipote Rabbi Yehuda Nesi’ah I. Tuttavia, il suo bisnipote, Yehuda Nesi’ah II, cambiò questa politica. Questo Yehuda, disperato per la possibilità di cambiare la legge dei Saggi sulla questione dell’eredità della figlia, nominò per la prima volta giudici che non erano Saggi, aspettandosi che decidessero in modo diverso. Infatti, sentiamo di vari Maestri della terza generazione in poi che criticano aspramente giudici che furono nominati al loro ruolo in virtù del loro denaro e ricchezza, e sono chiamati nelle fonti “eilin demitmanin bekesef” (coloro che sono nominati con denaro). Da queste critiche apprendiamo che il Principe in questo periodo nominò giudici che non erano Saggi e non erano adatti a ricoprire questo ruolo.
La zona crepuscolare
In passato i ricercatori hanno cercato di spiegare in vari modi la politica delle nomine del Principe. È particolarmente noto l’articolo classico dello storico Gedaliahu Alon, “Eilin demitmanin bekesef”, in cui propose che i Principi lo facessero sulla base di un approccio democratico di rispetto per le comunità locali e i loro giudici (che non erano Maestri), insieme al desiderio di adottarli sotto la loro protezione. Matar respinge questa interpretazione. Ritiene che Yehuda Nesi’ah II non lo fece per ragioni così nobili, ma aspettandosi che i nuovi giudici che nominò avrebbero accettato la sua opinione e equiparato l’eredità della figlia con quella del figlio maschio, e forse avrebbero deciso secondo le concezioni accettate dall’aristocrazia ebraica anche in altre questioni civili. A seguito di questa politica si sviluppò una competizione tra i tribunali dei Maestri e quelli del Principe. A un certo punto Yehuda Nesi’ah chiese all’imperatore Diocleziano di intervenire nella controversia e di stabilire che il Principe fosse l’unica autorità a nominare giudici. L’approvazione fu ricevuta in un decreto imperiale emesso nel 293, che stabiliva che solo un giudice nominato ufficialmente, cioè dal Principe, era considerato un giudice, e solo la sua decisione aveva la validità di un atto del tribunale che sarebbe stato riconosciuto dalle autorità. La tensione tra i tribunali del Principe e quelli dei Maestri continuò a occupare i Maestri e il pubblico per tutto il periodo, fino alla chiusura del Talmud gerosolimitano intorno all’anno 400 d.C.
Questo caso illustra il grado di creatività necessario per raccontare una storia del genere. A tal fine è stato necessario collocare la controversia sull’eredità della figlia nel contesto della legge romana, proporre il contesto sociale e collegare il confronto sulla nomina dei giudici a questo episodio. Naturalmente è possibile anche porre punti interrogativi su proposte e collegamenti come questi, che non emergono dalle fonti stesse ma sono frutto delle ipotesi dell’autore. L’autore ne è ben consapevole e nell’introduzione al libro descrive il suo lavoro come chi “opera in una zona crepuscolare, nel mezzo tra una ricerca accademica accurata e ricca di note a piè di pagina e un romanzo storico movimentato e creativo”. Aggiunge e scrive: “Non sostengo né posso sostenere di aver scoperto la verità storica assoluta di tutte le affermazioni presentate in questo libro e accolgo con favore critiche e discussioni oggettive da parte dei lettori. Tuttavia, spero di essere riuscito a creare un quadro utile per riflettere su questo periodo cruciale”.
Infatti, l’autore è riuscito nella sua missione di proporre un quadro interessante e utile per comprendere questo periodo importante e centrale, e i lettori sono invitati a esaminarlo in modo critico. Il libro è accompagnato da un ricco elenco bibliografico e da indici per argomenti e fonti discusse in esso. Questo libro è raccomandato a chiunque ami la storia del popolo d’Israele, ed è un libro obbligatorio per chi si interessa alla storia d’Israele nel periodo della Mishnà e del Talmud.
