Il rabbino britannico Jonathan Sacks è stato una figura di spicco dell’ebraismo. Adesso arriva in italiano la serie dei suoi commenti ai testi Ietti al sabato in sinagoga: ne emerge un’interpretazione diversa da quella a cui si è abituati
Marco Rizzi – La Lettura – Corriere della Sera
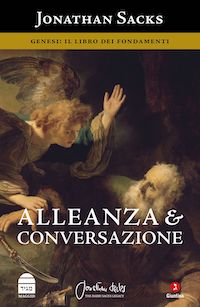
Jonathan Sacks è stato una figura di spicco nelle vicende dell’ebraismo tra XX e XXI secolo. Era nato a Londra nel 1948 — non ha quindi vissuto di persona il dramma della Seconda guerra mondiale — e lì ha vissuto, formandosi come rabbino ma conseguendo anche titoli accademici a Cambridge e al King’s College di Londra, sino ad assumere la guida della Sinagoga Unita di Londra e divenire Gran Rabbino delle comunità ebraiche ortodosse del Regno Unito e del Commonwealth dal 1991 al 2013. Nel 2001 gli fu conferito un dottorato honoris causa in teologia dalla Chiesa Anglicana e la regina Elisabetta lo ha creato baronetto (Sir) nel 2005 e Lord nel 2009 (con il relativo seggio alla Camera Alta). Sacks è morto nel 2020, lasciando la moglie e tre figli. Qualcuno forse ricorderà di averlo visto inquadrato dalla Bbc durante la cerimonia delle nozze tra il principe William e Kate Middleton. Queste osservazioni, apparentemente banali, sono importanti per chiarire la sua posizione nel contesto dell’ebraismo contemporaneo e il rilievo della sua figura e della sua opera intellettuale.
La corrente ortodossa dell’ebraismo, cui Sacks apparteneva, interpreta il testo biblico alla luce della tradizione rabbinica più antica, canonizzata negli scritti della Mishna (II secolo) e del Talmud (dal IV secolo in poi); i suoi capisaldi sono l’assoluta veridicità e normatività della Torah (i primi cinque libri della Bibbia, o Pentateuco), in quanto consegnata direttamente sul Sinai da Dio a Mosè, e la stretta osservanza delle 613 mitzvot («precetti», «norme») da essa derivate, tra cui le più note sono quelle relative all’alimentazione; secondo questa visione, che esclude ad esempio la possibilità di una interpretazione storica e critica del testo biblico, solo così è possibile garantire la continuità del patto tra Dio e il suo popolo. Tuttavia, l’ebraismo ortodosso si differenzia al suo interno su molti altri aspetti, quali ad esempio l’abbigliamento, l’opportunità di svolgere una professione, più in generale il rapporto con il mondo contemporaneo e con i non ebrei in esso: i brevi cenni biografici lasciano facilmente intendere quale fosse l’attitudine di Sacks.
È quindi ottima l’iniziativa della casa editrice Giuntina di tradurre, con il sostegno del Miur e del Cnr, la serie dei 5 volumi che raccolgono il commento di Sacks alle parashot, ovvero le sezioni della Torah che vengono lette in sinagoga il sabato. Si tratta di qualcosa di analogo alla predica sul Vangelo della domenica, con la differenza che nel caso dell’ebraismo ogni anno deve essere letto l’intero Pentateuco, partendo dalla Genesi e finendo con il Deuteronomio; le porzioni di testo lette risultano più estese e il commento può spaziare tra i molti temi possibili. Certamente l’imponente opera di Sacks è mirata anche a un pubblico non ebraico, nel tentativo di mostrare quale sia la visione del mondo di un ebreo ortodosso a partire dal testo biblico. Tuttavia, ancor più che per i contenuti proposti, queste pagine possono risultare interessanti perché mettono in contatto con una modalità di lettura del testo biblico abbastanza diversa da quella a cui si è abituati dall’esegesi e dalla predicazione cristiana attuale.
In questo senso, esemplare è il commento di Sacks a quello che definisce «l’incipit più famoso e maestoso di ogni libro dell’intera letteratura», ovvero il primo versetto della Genesi: «In principio Dio creò i cieli e la terra». Per Sacks, «per comprendere la Torah dobbiamo leggerla come Torah, cioè come legge, apprendimento, insegnamento, guida» e quindi l’insegnamento fondamentale della Torah riguarda il «come vivere». A questo punto, Sacks allarga lo sguardo all’intera parashah che oltre al racconto della creazione comprende la storia di Adamo ed Èva, quella di Caino e Abele e si conclude con Dio che si rammarica della malvagità delle sue creature e decide di mandare il diluvio a punirle. Ciò gli offre lo spunto, tra le altre cose, per una riflessione su religione e violenza che oggi pare straordinariamente attuale. Dall’atto creatore di Dio discende, ipso facto per Sacks, la sua assoluta proprietà e sovranità sul mondo: perciò la sua promessa conferisce un diritto che «rende la rivendicazione della terra da parte del popolo ebraico differente da quella di qualsiasi altra nazione» e «non deriva da eventi casuali di insediamento, organizzazione storica, conquista o accordi internazionali (anche se tutti e quattro questi elementi valgono nel caso dell’attuale Stato d’Israele). Nasce da qualcosa di più profondo: la parola di Dio stesso — quel Dio riconosciuto di fatto da tutti e tre i monoteismi: ebraismo, cristianesimo e islam».
Sin qui, sarebbero d’accordo con Sacks anche Itamar Ben-Gvir o John Hagee, il leader dei cristiani sionisti americani, vicino a Trump. Con una mossa tipica della lettura rabbinica della Bibbia, Sacks non nega questa interpretazione della parashah, definita una «lettura politica», ma propone di aggiungerne un’altra «non alternativa, ma supplementare», che di fatto limita di molto il valore della precedente. Citando i versetti relativi alla creazione dell’uomo, Sacks individua nella sua libertà e responsabilità le caratteristiche che lo rendono «fatto a immagine e somiglianza di Dio». Così, in quanto nel suo atto creativo e di dono, Dio è assolutamente libero, anche l’uomo è libero e l’intera Torah è per Sacks «un appello all’uomo perché eserciti responsabilmente la libertà creando un mondo sociale che rispetti la libertà altrui».
Ma la vicenda del primo omicidio mostra l’uso degenerato della libertà, proprio in connessione con la religione: Caino uccide Abele perché il suo sacrificio era stato rifiutato, mentre quello del fratello accolto con favore da Dio. Per Sacks, l’ira di Caino mostra che la sua offerta non era gratuita, bensì un atto che esigeva un contraccambio, mentre quella di Abele un atto di umiltà. La violenza (anche religiosa) si configura come l’imposizione della propria volontà con la forza. Ci sono solo due modi di convivere con la colpa che ne consegue — conclude Sacks: «Negando Dio, come fa Nietzsche, o affermando di compiere la volontà di Dio, come fa Caino. L’unica alternativa — l’alternativa della Torah — è considerare la vita dell’uomo sacra. Questa rimane l’ultima, sola speranza dell’umanità».
Giovedì 18 settembre 2025 il Teatro Torlonia di Roma ospiterà in anteprima nazionale la presentazione del libro ALLEANZA & CONVERSAZIONE – Genesi. Il libro dei fondamenti di Rav Jonathan Sacks z.l.
Intervengono: Rav Riccardo Di Segni · Fiorella Bassan · Gianni Yoav Dattilo · Shulim Vogelmann.
Modera: Lara Crinò
Prenotazione obbligatoria: centrocultura@romaebraica.it
