Sugli eroi, le liberazioni e le guerre – Le feste ebraiche, Jaca Book 2010
Yeshayahu Leibowitz z.l. (1903-1994)
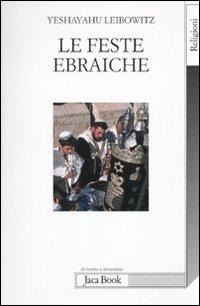
Alla pace, nella tradizione ebraica, è assegnato un grandissimo valore. Secondo questa concezione, già nella Scrittura, così come nel mondo della Torah orale, nella halakhah e nella aggadah, a essa è riservato il valore più alto, ed è persino uno dei soprannomi del Santo, benedetto Egli sia. Allo stesso tempo, di fatto, la storia dell’uomo, nel mondo, e la storia d’Israele, nella sua terra, abbondano di guerre, e la guerra contro gli Asmonei è una di queste, guerra che il popolo ebraico combattè in un periodo in cui possedeva l’indipendenza nazionale ed era in grado di combattere. Sul significato di questa guerra dobbiamo ora soffermarci.
Esistono due punti di vista opposti, riguardo alla guerra. Il primo punto di vista rigetta totalmente la guerra, ossia non l’accetta né la accoglie a nessuna condizione e in nessuna circostanza. Questa prospettiva considera l’uomo, in quanto individuo, come il valore supremo, che determina ogni cosa, e la questione della conservazione della sua esistenza come l’obbligazione suprema, che per nessuna ragione o motivo è possibile rimandare; e per niente al mondo è possibile sacrificare la vita dell’uomo. Questa visione è conosciuta con il nome di pacifismo.
Contrapposto a questo punto di vista ne esiste anche un altro, che pone la guerra o, per essere più precisi, il valore dell’uomo che combatte, a un livello assai elevato, a volte senza nemmeno considerare per che cosa l’uomo combatte, e perché vada a uccidere o, naturalmente, a essere ucciso.
Dallo studio di tutte le fonti ebraiche, dalla Bibbia, la halakhah e la aggadah, si deve dire che non emerge nessuna forma di pacifismo, e che la guerra è riconosciuta come un dato della realtà umana. Il realismo del mondo della Torah e dei precetti, realismo che giunge sino alla crudeltà, fa riferimento al mondo così come esso è, e non a un possibile mondo frutto di una visione, e ciò in contrapposizione alle concezioni diffuse a volte, ai nostri tempi, tra i pensatori che si occupano di ebraismo, come se la visione degli ultimi giorni della storia, contenuta nel passo «dimorerà il lupo con l’agnello», fosse la vera essenza dell’ebraismo. Tuttavia le cose non stanno così, in quanto l’ebraismo tratta della condizione dell’uomo dinanzi al Signore nel mondo reale, che non è per niente ordinato, e in cui esistono le guerre, che sorgono per i conflitti di interesse che gli istinti degli esseri umani non permettono di risolvere con la pace. Perciò la Torah scritta, così come quella orale, si occupa, tra le altre cose, anche delle guerre. A partire da queste questioni riguardanti l’insieme degli uomini, è possibile fissare, per una specie di analogia, delle regole per l’uomo, in quanto individuo, nella sua vita.
I sei ordini della Mishnah rappresentano, com’è noto, la tradizione legale cristallizzata del giudaismo; e qualsiasi persona, che conosca i testi del giudaismo, sa che, dal punto di vista quantitativo, l’ordine della purezza, tra tutti e sei gli ordini, è quello che occupa il maggior spazio. Di che cosa si occupa? Del sangue della mestruante, del sangue del parto, del sangue della mestruazione, di membrane e di placenta, di piaghe, di vermi, d’impurità degli utensili, delle impurità del corpo, delle emissioni seminali, e del cadavere, causa prima dell’impurità, ossia di ogni contaminazione biologica dell’esistenza umana. Per quale ragione? Perché questo è l’uomo, e poiché la Torah si occupa dell’uomo, qual è nel suo mondo, essa non può trascurare ciò che ne contamina l’esistenza.
In analogia a ciò, si può dire che, di fatto, le guerre stesse costituiscono una contaminazione sociologica e comunitaria dell’esistenza umana, e perciò, come abbiamo detto, sia la Torah sia la halakhah si occupano anche di esse.
