Alberto Cavaglion – Camillo Berneri, L’ebreo antisemita , Roma, Carucci 1984
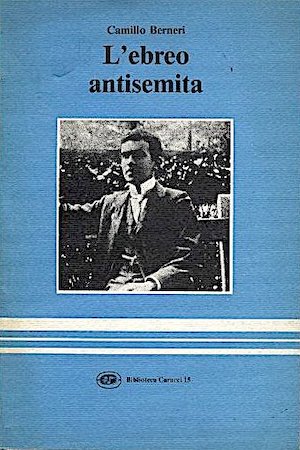
Non è facile per chi non sia anarchico ma ebreo parlare di un libro che un anarchico non ebreo ha consacrato al tema forse più scabroso della storia ebraica: l’antisemitismo semita. Mescolando un po’ le carte, sarebbe come per un ebreo comunista descrivere la psicologia di un trotzkista, o per un trotzkista la mentalità di uno stalinista. O meglio ancora — per entrare subito nel vivo della storia di Camillo Berneri — sarebbe come per un allievo di Salvemini, per un collaboratore di Gobetti parlare di un amico antifascista che ha preferito la strada del conformismo, oppure per un anarchico fuggito a Parigi dopo le leggi fascistissime, addentrarsi nel ginepraio dei delatori, delle spie, dei professionisti del doppio-gioco.
L’imbarazzo però viene meno se soltanto si sfoglia qua e là questo sottile volumetto pubblicato in francese dall’editore «Vita» nel 1935 (con titolo vagamente molièriano: Le Juif antisémite) ed ora tradotto per la prima volta in italiano, per iniziativa dell’Archivio Famiglia Berneri di Pistoia, nella versione di Rosa Zotto.
Il giovanile spirito libertario di Berneri rassicura immediatamente il lettore perplesso. C’è innanzitutto la freschezza dei principi anarchici: «Non ho considerato i casi di quegli ebrei che, in quanto uomini di governo, hanno mancato ai doveri di solidarietà verso i loro correligionari. Ho ritenuto del tutto normale un atteggiamento di questo genere: l’esercizio del potere rende vili, crudeli ed ingiusti». Si noterà poi il continuo raffronto tra il pregiudizio antisemita e il problema dell’apartheid: «Il negro della capanna dello zio Tom fa lagrimare persino gli occhi americani, ma il negro elegante con un’amante bionda al suo fianco, fa gridare, ancora oggi, al linciaggio». In una battuta degna del miglior Salvemini, l’autore esclama poi, con voce dal sen fuggita: «La morte di un antisemita è una delle cose che più sollevano il mio cuore».
Infine, è in qualche modo rivelatrice la sottile ironia che avvolge le riflessioni berneriane intorno ad un testo del Cinquecento: Dernière profession de foi de Simon Sinai, de Lucca, avant catholique-romain, après calviniste, par la suite luthérien, nouvellement catholique mais toujours athée. Da buon anarchico Berneri diffida di ogni conversione, sincera od opportunista. Da buon anarchico non tollera «le finte lune di miele mistiche», non sopporta i voltagabbana e le banderuole. Detesta il nicodemismo.
Le Juif antisémite vuole essere dunque, innanzitutto, la professione di fede di un militante leale e coerente, nemico giurato dei molti trasformisti del tempo suo.
Ma non è soltanto la limpidezza di questo libro ad attirare la nostra curiosità.
Nel panorama piuttosto desolante della letteratura sugli ebrei — opera di autori non ebrei — il lavoro di Berneri si presenta davvero come un unicum. La nostra cultura novecentesca, infatti, si caratterizza per un’assoluta impermeabilità tra intellettualità laica e intellettualità ebraica. Due compartimenti stagni. Anche i personaggi di più larghe vedute spesso hanno ignorato l’esistenza di questa entità di minoranza ed in fondo hanno accettato gli ebrei proprio perché non sapevano che fossero ebrei. Si cita di solito il caso limite di Benedetto Croce, responsabile di alcuni affrettati giudizi sulla comunità israelitica italiana. In tale contesto l’operina di Camillo Berneri, nella sua scrupolosissima documentazione e nella trasparente sua onestà, merita di essere conosciuta.
Il fatto che sia scritta in francese e abbia come oggetto un argomento così scomodo non deve sorprendere. È semplicemente la dimostrazione paradossale di una situazione paradossale, la bizzarra eccezione che conferma la regola di un lungo silenzio, rotto solamente da molte, rumorose ciarlatanerie. Per fare un unico confronto, si pensi che Gog di Papini è di questo stesso giro di anni e si legga il giudizio spietato di Berneri verso questo prototipo dell’opportunismo, verso questo paladino della trahison: «Giovanni Papini, che in gioventù bestemmiava contro il Cristo pederasta, rivelava il suo complesso d’inferiorità e le sue proteste nel romanzo Un uomo finito, ma era naturalmente destinato a scrivere la Storia di Cristo e a finire rettore dell’Università Cattolica di Milano».
Come quasi tutti i libri di Berneri, Le Juif antisémite fu scritto in poche settimane, usando la tecnica del collage cara a Salvemini. I libri, precisa l’autore nella premessa, vanno riempiti di fatti, non «imbottiti di stoppa». E del libro-dossier ha tutte le prerogative, compresi i difetti, come notò quasi subito un altro fuoruscito, compagno di Berneri, espulso nel 1929 anche dalla Francia e costretto a riparare in Belgio, Alberto Jacometti, che in una lettera scrive: «Tu non hai fatto che impostare, inquadrare il fenomeno. Di qui una certa aridità. Hai messo lì lo scheletro e non l’hai rimpolpato. È un po’ il genere tuo che si ritrova in svariati tuoi articoli (seguo attentamente quelli dell’Adunata — bellissimi alcuni); il tuo lavoro di ricercatore è sovente troppo nudo. Per fare un paragone ti dirò che sei un po’ come un minatore che trovato un diamante pronto te lo mette nelle mani». Se si considerano però le condizioni in cui queste pagine vennero composte non si può non rimanere esterrefatti per la varietà e la vastità della ricerca. Il breve studio fu portato a termine all’alba della guerra di Spagna e, soprattutto, alla vigilia della scomparsa del suo autore, morto a Barcellona il 5 maggio del 1937, assassinato da agenti staliniani, al culmine della contesa tra comunisti ed anarchici. Converrà rileggere i passaggi dedicati ai contrasti tra sefarditi ed askenaziti, alle lotte fratricide, proiettandoli nella realtà di quei mesi, dei litigi all’interno della Concentrazione. L’insistenza con cui Berneri parla delle diatribe tra convertiti ed ortodossi, ai tempi dell’Inquisizione spagnola, ha qualcosa di tenebrosamente profetico.
Le Juif antisémite è un lavoro concepito per un pubblico francese. Come ricorda Pier Carlo Masini, gli anni del soggiorno parigino furono i più intensi — ma anche i più difficili — nella breve esistenza del giovane, originario di Lodi. Braccato da più di una polizia, afflitto da gravi problemi di sussistenza, senza una biblioteca sua o una stanza per lavorare, stendeva molti dei suoi lavori sui tavolini di un bistrò: «Trattava i libri come fossero abiti vecchi da rivoltare: li scuciva, li faceva a pezzi, gettava via — magari dai finestrini del tram! — le parti che non interessavano, intercalava o incollava parti di altri libri, inseriva ritagli di giornali, appunti». Si interessava di tutto, portava avanti, contemporaneamente, più di un progetto di ricerca «a tal punto che la sua attività intellettuale è influenzata e condizionata da questo suo impegno, nel bene e nel male (nel bene come continuo contatto con la realtà, con i tempi, con la storia, quindi un lavoro e una produzione vivi, tesi, non rilassati e accademici; nel male come eccesso di scritti frettolosi, non sufficientemente meditati e curati, spesso imposti dall’urgenza e posti al servizio della minuta propaganda giornaliera)». «Si interessava di tutto», scriverà molti anni più tardi Salvemini: «Mentre molti anarchici sono come case le cui finestre sulla strada sono tutte murate (a dire il vero, non solo i soli!), lui teneva aperte tutte le finestre».
Nel 1935 Berneri era da circa dieci anni a Parigi. Aveva quindi un quadro abbastanza preciso della question juive, in una città che andava ancora leccandosi le ferite dell’affaire. La bibliografia che chiude il libretto, salvo poche eccezioni, è interamente composta di voci francesi. E questo non soltanto per ovvie ragioni pratiche. Ma anche perché a Parigi, più che a Firenze, aveva un significato politico «aprire una finestra» sulla fenomenologia della haine de soi juive. Aveva, in altre parole, un senso pratico-operativo, capace di infiammare Tammo di un uomo d’azione come Camillo Berneri. L’ingiustizia subita dal giovane scolaro ebreo — un classico nella tradizione letteraria d’oltralpe: da Spire alla recente ouverture del pamphlet di A. Finkielkraut, Le Juif imaginaire — indigna il socialista proudhoniano e umanitario, l’anarchico in esilio a Parigi.
La haine de soi riportava alla memoria di Berneri un personaggio latino: il terenziano «punitor di se stesso». L’ebreo come novello Heautontimoroumenos. Totò Merumeni, direbbe Gozzano. «Et je ferai de ta paupière, pour abreuver mon Saharah, jaillir les eaux de la souffrance», scrive Baudelaire in una poesia dei Fleurs du mal, intitolata appunto Héautontimorouménos: un breve componimento che potrebbe essere eletto ad epigrafe di questo libretto. «Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde». «Je suis de mon coeur le vampire, — Un de ces grands abandonnés au rire éternel condamnés, et qui ne peuvent plus sourire!».
Berneri era un lettore dei classici latini, oltre che di Baudelaire, ma nel suo manoscritto preferisce riportare per intero uno dei Poèmes Juifs di Spire più appassionatamente ispirati alla figura del déraciné, cioè a dire, nell’interpretazione berneriana, al moderno «punitor di se stesso». Ed ai lettori di Spire (e di Bernard Lazare) è rivolto questo quaderno, le cui informazioni, più opportunamente, andrebbero oggi riversate nel dossier di Michael R. Marrus, Les Juifs de France à l’époque de l’affaire Dreyfus, piuttosto che nella Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo di Renzo De Felice.
Eppure, più di un residuo della permanenza fiorentina viene a galla. S’è detto della consuetudine con Salvemini, che scrive in un’altra testimonianza: «Conobbi Berneri nel 1919, quando venne a studiare alla Facoltà di Lettere a Firenze, dove ero professore di Storia Moderna. Siccome era la prima volta che avevo un anarchico fra i miei allievi, mi interessai a lui in maniera particolare. Divenne uno degli studenti che venivano spesso a passare le loro serate con me, discutendo dei loro studi, del loro avvenire, delle questioni del giorno, di tutto ciò che ci poteva interessare. Anche dopo aver compiuto i suoi studi a Firenze, continuò ad avere con me rapporti affettuosi». Si è inoltre ricordato il giudizio su Papini; si potrebbe poi aggiungere quello, anticlericaleggiante, contro Alessandro Manzoni («In gioventù aveva sognato di scrivere con lettere minuscole le parole: re, papa, imperatore ma era naturalmente destinato a cantare la Chiesa, la Monarchia, l’Impero»).
Stupisce, infine, che Berneri ricordi l’umanista Poggio Bracciolini, studente d’ebraico presso un insegnante ebreo convertito (ma il particolare è di seconda mano, tratto da Lazare), ed invece trascuri l’incunabolo dell’ebreo antisemita nella storia della letteratura italiana: la novella di Boccaccio della prima giornata del Decameron, la vicenda di Abraam Giudeo che, veduta a Roma la malvagità dei chierici, «torna a Parigi e fassi cristiano».
Prendendo spunto dalla bibliografia finale, tuttavia, si direbbero soprattutto tre i nomi «italiani» più rilevanti nella formazione del giovane studente universitario: Cattaneo, Lombroso e Weininger.
Del primo, giustamente, Berneri ricorda l’opuscolo sulle interdizioni. Anzi, dice che questo opuscolo vale infinitamente di più di quello marxiano sulla Judenfrage. Qui è ancora il concretismo di Salvemini a parlare, insieme alla ideologia anarchica: «Marx dice sempre le mie idee e non vuol capire che le idee non appartengono a nessuno. Le idee si cercano».
In qualche modo Cattaneo diventa l’alternativa a Marx: «Considero Karl Marx antisemita non a causa di ciò che ha scritto sugli ebrei, ma a causa di ciò che non ha scritto, detto e fatto a favore degli ebrei»; «Marx non ha mai preso a cuore e seguito con Vivo interesse la questione ebraica, né ha cercato di conoscerla nei particolari. Quello che dice sugli ebrei non è interamente falso, ma unilaterale e infarcito di generalizzazioni deteriori (tipiche del resto del suo stile intollerante ed …hegeliano)». Più che di antisemitismo vero e proprio si tratterebbe di un reato di omissione di soccorso.
Nel capitolo «Karl Marx, antisemita» la rivalità anticomunista è fin troppo evidente — non a caso il ritratto di un Marx ipocondriaco, tutto dedito ai cetriolini, al caviale e ai cazzotti cosacchi, è modellato sulla biografia eterodossa di Otto Ruhle. Ma il cattaneismo salveminiano non va sottovalutato. Secondo Berneri il problema ebraico andrà risolto con impegno e attenzione quotidiani, al di fuori di ogni metafisica scuola «braminica», hegeliana o marxista che sia.
Di Cesare Lombroso, Berneri ricorda la monografia del 1894, che fece scuola in Italia, all’inizio del secolo. Lombrosiane sono l’impostazione e la struttura stessa del libro (si vedano i titoli dei capitoletti); ed ancora condizionata da una mentalità di tipo posi tivistico è l’arcaica tripartizione che l’autore propone tra antigiudaismo, antimosaismo e antisemitismo. Anche il lessico risente della temperie medico-antropologica di fine secolo. L’antisemita semita «ebreofago» è un divertente neologismo bernenano, ma «lotta per l’adattamento», «eredità sociali», «inferiorità sociale» fanno naturalmente parte del bagaglio lombrosiano. Senza trascurare il famigerato termine «razza», autentica invenzione del positivismo, che Berneri sa smascherare con abilità, ma in fondo accetta e continua ad usare per tutto il suo scritto.
A Firenze, oltre che con Salvemini, Berneri aveva lavorato con Enzo Bonaventura, autore di un manuale divulgativo sul pensiero freudiano. Ebreo tutt’altro che antisemita (morirà in Palestina nel 1948, in uno scontro a fuoco con gli arabi), Bonaventura tenne a Firenze, nel primo dopoguerra, un corso sulla psicanalisi che vide Berneri tra i più assidui e attenti ascoltatori. È miscelando il ricordo delle conversazioni con Bonaventura insieme alla lettura folgorante dell’edizione francese, curata da Marie Bonaparte, del Ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci, che l’anarchico inizia a riflettere sull’opera freudiana, sulla libido e sul réfoulement (ma i lettori troveranno in quest’opera anche una lunga citazione da Adler). Il nome di Freud compare nell’elenco dei destinatari stilato da Berneri stesso, per gli omaggi. Ai ricordi d’infanzia di Leonardo è dedicato un apposito studio. Per tutte queste ragioni Le Juif antisémite, dopo Marrus e De Felice, va inserito nel dossier di Michel David, su La psicoanalisi nella cultura italiana: la figura di Berneri costituisce un capitolo importante nella stona della prima, travagliata penetrazione di Freud in Italia.
Terzo nume tutelare, dopo Cattaneo e Lombroso, e Otto Weininger il filosofo austriaco naturalizzato fiorentino da Prezzolini, ai tempi della prima «Voce». Di Sesso e carattere, specifica Berneri in una nota, «non esiste traduzione francese». Ed ha ragione. Fino al 1975 la cultura francese rimarrà insensibile alla sessuologia weiningeriana. Quando la Bonaparte suggeriva ai suoi concittadini l’interpretazione psicanalitica dei sogni infantili di Leonardo, il nome di Weininger, idolatrato dai collaboratori di Prezzolini, era in Francia del tutto sconosciuto – noto solamente a André Spire, come riconosce anche Berneri.
Dall’Italia, l’anarchico fuoruscito aveva invece portato con sé una copia della seconda edizione di Sesso e carattere (1922), magari tagliuzzata nel capitolo dedicato allo Judische Selbsthass, variante danubiana della haine de soi juive: «Weininger sottopose ad analisi la sua opera e scoprì particolari spaventosi».
Sarebbe interessante — ma non è questa la sede più adatta per una divagazione di questo tipo — allargare il discorso, ed estendere le ipotesi di Berneri alla cultura ebraica del Novecento italiano. Weininger non fu il solo «cattivo maestro». C’era Renan, c’era Zweig. E l’hic sunt leones dei vecchi cartografi potrebbe non esaurirsi nell’elenco, già abbastanza lungo, dei weiningeriani nostrani: da Giulio Augusto Levi, primo scopritore delle doti autopunitive del viennese, a Giacomino Debenedetti, il quale in certi giudizi su Saba e in un saggio, che è di capitale importanza nella storiografìa sveviana, ci ha lasciato un ritratto del progenitore asburgico dell’antisemitismo semita molto simile a quello tracciato da Camillo Berneri: «Weininger ha assunto quel tono di apologia a rovescio, particolare all’antisemitismo degli ebrei, in cui l’odio e l’amore più sviscerati vanno commisti in un abbraccio mostruoso; e la proterva volontà di un’evasione impossibile e illecita è sempre pronta a risentirsi in una angosciosa solidarietà di razza che, come una ferita non mai chiusa, grida all’appressarsi del più piccolo accenno offensivo».
La presenza in bibliografia di un nominativo della finis Austriae non dovrà trarre in inganno. All’orizzonte culturale di Camillo Berneri è estraneo il versante mitteleuropeo. Come si è visto, Le Juif antisémite è un libro destinato ad un uditorio francese. Il mito austro-ungarico brilla per la sua assenza. A tal punto che non troviamo cenno, nemmeno in una noticina a pié di pagina, di un libretto che si può dire gemello a quello di Berneri. Lo pubblicò nel 1930 un ebreo di Hannover, Theodor Lessing, nella autorevole collana sionistica (e buberiana) della Judischer Verlag. S’intitolava Der Judische Selbsthass e si trattava di un’iniziativa in tutto identica a quella dell’anarchico italiano, anche nell’impostazione psicologica. Ma era un’impresa portata a termine con materiale austriaco o tedesco, da uno studioso non anarchico, celebre per una prolungata querelle con Thomas Mann. Berneri non poteva sapere che un suo collega aveva avuto un’idea identica alla sua, certo avrebbe divorato in poche ore Der judische Selbsthass, se soltanto qualcuno avesse avuto l’opportunità di segnalarlo alla sua curiosità onnivora — ma nemmeno Spire, che dopo il 1935 fu amico di Berneri, conosceva Lessing.
Tragico destino sembra accomunare le biografie «maledette» degli storici dell’odio di sé. Morto per mano degli stalinisti Camillo Berneri; trucidato da un manipolo di nazisti giunti appositamente a Marienbad nel 1933, Theodor Lessing, al termine di una esistenza non immune dalla piaga dello judische Selbsthass (convertitosi in un primo tempo al luteranesimo, Lessing sublimò la conversione aderendo poi al sionismo e prodigandosi nell’attività antinazista). Le sue memorie, Einmal und nicht wieder, uscite postume nello stesso anno del saggio di Berneri, avrebbero potuto costituire un’ulteriore pezza di appoggio all’indagine dell’anarchico.
I protagonisti del libro di Lessing provano gli stessi sintomi individuati da Berneri e curati dal loro quasi concittadino Freud: masochismo, complesso di inferiorità, bisogno di evasione, volontà ribelle. Ma — escluso Weininger — hanno altri nomi: Pau Rée, l’ambiguo amico di Nietzsche e di Lou Salomé; Arthur Trebitsch, nazionalista poligrafo, autore di velenosi attacchi contro lo Judentum; Max Steiner, filosofo suicida come Weininger; Walter Calé, poeta suicida affetto dalla nausea di sé; Maximilian Harden, giornalista bismarckiano, direttore del settimanale «Zukunft», dove, nel 1897, Walther Rathenau, fedele prussiano, industriale di successo, futuro primo ministro di Weimar ucciso in un attentato nel 1922, pubblicherà quell’Hore Israel (Ascolta, Israele), che è forse in assoluto il più caustico manifesto dell’ebraismo antisemita.
Anche Berneri chiude il suo libro con un appello: «Ascolta, Israele». Ma di ben altra natura. L’ebreo «universalista» e cosmopolita, che faticosamente tenta di superare l’impasse tra assimilazione e ortodossia, tra assimilazione e nazionalismo, è il suo modello ideale: «Ma al di sopra di queste due posizioni estreme ne esiste una terza: quella di un universalismo ebraico, in grado di compiere una missione, capace di costituire il tessuto connettivo, il sistema capillare dei popoli». «Sono i senza patria i più adatti a fondare le basi della grande famiglia umana». Un mònito contro «i fili spinati dei pregiudizi nazionali e di casta», che ricorda l’esortazione finale del saggio L’Ebreo-non ebreo di Isaac Deutscher, il maggiore biografo di Trotzkij: «Perciò la mia speranza è che gli ebrei, e così le altre nazioni, si accorgano infine, o di nuovo, dell’inadeguatezza dello stato nazionale, e ritrovino l’eredità politica e morale lasciata dal genio di questi ebrei che andarono oltre l’ebraismo: il messaggio di un’emancipazione universale dell’uomo». Berneri non fece in tempo a conoscere gli effetti nefasti della campagna razziale, ma è pienamente consapevole della drammaticità del momento. «L’antisemitismo», leggiamo sempre nella suggestiva pagina conclusiva, «sarà ancora per lungo tempo all’ordine del giorno della stupidità umana».
Questa, a tratti molto sommari, una possibile chiave di lettura. Il costante rifiuto del fedifrago rappresenta il sottofondo del libro. Berneri evoca Paolo di Tarso, primo convertito «sincero», ma non parla dello storico della Guerra Giudaica, Flavio Giuseppe, capostipite sui generis dell’ebreo transfuga, teorico, secondo Pierre Vidal-Naquet, del «buon uso del tradimento». Ma il discepolo di Bakunin, l’erede di Pisacane non accetta compromessi. Nessun uso del tradimento. Né buono né cattivo.
Molte altre potrebbero essere le considerazioni suggerite da un’attenta lettura. Qui si possono soltanto elencare alla rinfusa. Innanzitutto la sottile acutezza dell’analisi psicologica, che in certi punti — per esempio nel capitolo su Disraeli — ricorda Hannah Arendt. Anche Berneri si serve del termine paria, pur non opponendolo esplicitamente al parvenu; anche Berneri giudica la stagione dell’emancipazione come la più difficile per il popolo ebraico nell’età dei totalitarismi: «Gli ebrei hanno conosciuto il peso delle catene, della schiavitù, l’ombra maleodorante dei ghetti, la vergogna chiassosa delle strade. Oggi conoscono il peso dell’emancipazione. Non si è mai tanto schiavi quanto nel momento in cui si ha la coscienza di esserlo». D’altra parte proprio da un’ebrea «antisemita» come Rachel Varnhagen la Arendt aveva iniziato i suoi studi sull’ebraismo contemporaneo.
Berneri insiste molto sull’orgoglio, sul desiderio di eccellere degli scolari modello, sulle manie di grandezza dei catecumeni, facendo venire in mente un luogo di Poesia e conoscenza di Hermann Broch, oggi più volte menzionato per spiegare le ambivalenze di Kafka o di Svevo. Broch parla del singolare «antisemitismo» interiore degli ebrei assimilati e allude ad una forma speciale di narcisismo.
Ma il legame tra Broch e Berneri, a essere sinceri, ha poca consistenza sul piano dei fatti. Altre — e più sicure — sono le parentele che abbiamo cercato di individuare, sia pure in rapida carrellata. Altri ancora sono i quesiti che rimangono aperti, storicamente più pressanti. Per esempio: quale giudizio potrà aver dato di questo lavoro Enzo Bonaventura, il maestro segreto di Berneri? Bonaventura non risulta dall’elenco degli omaggi, ma è chiaro che, nel periodo compreso tra il 1935 e il 1938 (data dell’emigrazione in Palestina) avrà avuto senza dubbio voluto sincerarsi delle conclusioni del suo antico allievo. E ancora, una seconda questione: quale ruolo può aver avuto nella stesura del presente libro l’amicizia con i fratelli Rosselli? Certo, un ruolo notevole, sebbene non si trovino notizie negli epistolari. Innanzitutto con Nello, che per primo seppe fare tesoro dell’insegnamento di Salvemini, «aprendo tutte le finestre» nell’ambiente un po’ chiuso dell’ebraismo giovanile italiano e pronunciando a Livorno, nel 1924, al congresso della federazione giovanile ebraica, uno storico discorso, che è a suo modo, ancora oggi, una rivendicazione «universalistica» contro l’ebraismo integrale. E poi Carlo Rosselli, con cui, in quello stesso 1935, Berneri intraprende una polemica sui rapporti tra anarchia e «Giustizia e Libertà».
Il destino ha voluto che, a un mese di distanza (Berneri il 5 maggio, i Rosselli il 9 giugno), tutti e tre perissero sotto i colpi dei nemici della libertà e della giustizia.
Cuneo, agosto 1983
